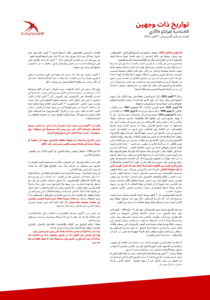L’editoriale del presidente di Rondine Franco Vaccari, pubblicato oggi, 7 ottobre, sul quotidiano Avvenire, è stato qui di seguito tradotto in arabo e in ebraico con la collaborazione di alcuni giovani di Rondine e affisso nella Cittadella della Pace, affinché tutti possano fermarsi a leggerlo e a riflettere insieme. Un gesto simbolico che dichiara l’intenzione di restare sempre in dialogo, anche quando è molto difficile, e invita tutti al dialogo e al riconoscimento gli uni degli altri, a partire dalla condivisione del dolore.
7 ottobre 2023. Una svolta tragica nel violento conflitto israelo-palestinese, un giorno che rimarrà scolpito nella memoria di entrambi i popoli. Una immediata e incontenibile moltiplicazione di odio che nella società globale ha infettato il mondo. Due anni dopo è difficile dire qualche parola che non accenda altro odio, perché è una data impregnata di odore di morte e non risolta ancora nel suo esito primo: gli ostaggi, i civili morti che continuano a morire. Ancora attendiamo la restituzione di persone e corpi. Ancora questa data è sottoposta alla drammatica tensione tra chi non vuole legittimamente minimizzarla o, peggio, archiviarla, chi, al contrario, vuole normalizzarla e chi, ovviamente, vuole enfatizzarla per tentare di giustificare ogni azione violenta successiva. Due anni dopo, certamente quella ferita non è stata curata con coraggio da una sapienza medico-politica ma si è squarciata, dilaniando tutto e tutti: quel sangue e quei lutti divenuti quotidiani traversano le coscienze dei protagonisti e, in modi assai diversi, quelle di tutti noi.
Il 7 ottobre 2023, come ogni data, segna un prima e un poi, apre la constatazione che sempre si ripete: «nulla sarà più come prima». Certe date dolorose, infatti, aprono fossati, la terra erutta veleni, nuove faglie separano per sempre.
24 febbraio 2022: la Russia invade l’Ucraina. 11 settembre 2001: il mondo entra nell’era del terrore globale. 6 luglio 1995 inizia il massacro di Srebrenica. 6 aprile 1994: inizia il genocidio in Ruanda. 6 agosto 1945: Hiroshima. Ogni volta un prima e un poi… e così all’infinito. Date che fanno dimenticare i lunghi processi da cui sono emerse e cristallizzano le narrazioni. Con queste date si può conservare dolore e odio, una contrapposizione permanente che frena e ritarda il futuro. Ma, pur essendo divisive, queste date non separano mai del tutto la storia umana che accanto ai traumi e alle separazioni più cruente, continua. Continua nelle memorie, nelle narrazioni, nei simboli, dai cimiteri alle titolazioni delle strade, ai libri di storia su cui si formeranno le generazioni successive. La storia avanza tra elaborazione onesta, oblio e revisionismo. E le date possono trasformarsi. Ricordo il 4 novembre, «Festa della Vittoria», quando il maestro ci portava in caserma a far festa e mi infilavo eccitato dentro un carro armato. Oggi il 4 novembre è cancellato giustamente dal calendario. Le date mutano, nel fluire della storia, possono diventare una soglia per incontrarsi anziché un muro per perdersi. Perché la ferita che separa le parti che si sono orribilmente uccise è paradossalmente l’unica porta ancora aperta. Se la data si sostituisce a un lungo e complesso processo, se resta unica traccia di mille dolori, unico racconto di quel giorno, regna e regnerà la divisione: due narrazioni inconciliabili rimbalzeranno per secoli come un’eco maligna di rabbia, dolore, odio. Le date, oltre a «un prima e un poi», come le pietre miliari, hanno due lati. Stanno tra due tempi, ma tengono insieme due spazi. Quando ci si fa del male, quando ci si fa molto male, il dolore scivola su due versanti che devono prima o poi ricongiungersi nella continuità della storia. Così la data è una soglia che collega due mondi, due dolori immensi e permette un cambiamento.
Per i palestinesi, il 7 ottobre è rottura brutale e inevitabile, grido di un popolo inascoltato. Per Israele, il 7 ottobre è lutto e smarrimento: la fine dell’illusione di sicurezza, un trauma che ha risvegliato l’eco della Shoah, il misconoscimento della propria identità culturale che inizia ad albergare nei cuori.I due lati della data si ripropongo in una continuità tragica che affonda le radici nel 14 maggio 1948, giorno che ha segnato l’inizio del conflitto, giorno in cui si annodano errori e orrori dell’epoca precedente: dalle terre conquistate, spartite, assegnate e frettolosamente abbandonate dagli imperi coloniali, alla Shoah, alla richiesta e concessione maldestra di risarcimento, al rifiuto di giungere a nobili compromessi e avviare una storia nonviolenta. Le narrazioni che ci giungono troppo spesso omettono elementi decisivi per tenere onestamente «pulita» quella data… Per Israele quello è il giorno dell’Indipendenza (Yom Ha-atzmaùt): nasce lo Stato ebraico, dopo millenni di diaspora e persecuzioni. Una festa nazionale di orgoglio e rinascita.
Per i palestinesi è la Nakbà — «la catastrofe»: centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire o espulse dalle loro terre. Stessa data, due mondi sostanzialmente bloccati e inconciliabili, mentre il dolore non accolto, non condiviso, è scivolato su due versanti senza comunicazione trasformandosi in rabbia e odio che hanno inquinato la storia.
Il 7 ottobre si configura così come l’apertura di un nuovo capitolo di questa storia senza pace, una tragica continuità della Nakbà. Le ferite aperte allora, mai sanate, sono tornate a sanguinare, riaffermando che la questione fondamentale – la vita, la terra, la dignità di due popoli – resta irrisolta.Dal lato politico palestinese, si sente spesso questa affermazione: «Il 7 ottobre è stato barbarie, ma chiedetevi cos’è stato ogni giorno a Gaza, per 16 anni e per tutti gli altri decenni nella Cisgiordania». E sul fronte israeliano, la risposta netta e decisa: «Il 7 ottobre ha segnato il confine oltre il quale non si può e non si potrà più parlare di convivenza. Israele ha il diritto — e il dovere — di difendere i suoi cittadini da chi vuole cancellarlo».
Il 7 ottobre recita nei due lati ostinati soliloqui, ancorati a due diritti in conflitto insolubile, un muro di parole e di comportamenti che allontana per sempre la giustizia e il reciproco riconoscimento. Una parete refrattaria che amplifica l’odio senza trovare fine.
Eppure, anche nel momento più cupo, emergono voci di riflessione e autocritica da entrambe le parti, che suggeriscono una possibile via d’uscita: «Abbiamo investito in muri, tecnologia, eserciti. Ma il 7 ottobre ci ha mostrato che la vera sicurezza non si costruisce ignorando l’altro. Abbiamo sottovalutato l’odio che cresce quando la disperazione non ha voce» (israeliani). «Il 7 ottobre ha portato al mondo la nostra tragedia, ma anche il nostro abisso. Ci siamo illusi che la violenza potesse spezzare le catene: ha solo moltiplicato le macerie» (palestinesi). Queste parole, se ascoltate insieme, aprono una fessura, una breccia sulla complessità di una realtà che non si riduce a bianco o nero, vittima o carnefice, nonostante le sproporzioni e le evidenti asimmetrie.
Dicono che il 7 ottobre non è solo una data da commemorare o da contestare, ma un monito. Un invito a riconoscere l’umanità nell’altro, anche quando sembra impossibile, per provare – almeno – a interrompere la spirale di violenza che divora vite innocenti.
La storia non si legge mai da un solo lato del calendario. Ogni data — anche la più celebrata, anche la più atroce — ha almeno due voci, due silenzi, due dolori.
15 maggio 1948: indipendenza per gli uni, catastrofe per gli altri. 7 ottobre 2023: terrore per gli uni, rivolta per gli altri. Ogni popolo ha le sue memorie, le sue date, ma troppo spesso le usa come confini, non come soglie, come ponti da transitare per accedere a un futuro di pace. Eppure, finché le date continueranno a dividere invece che unire, il futuro resterà prigioniero del passato.
Un giovane israeliano, mentre andavamo insieme all’ambasciata di Israele, a Roma, per la festa del 14 maggio, mi disse: «Ho scoperto che la nostra festa è considerata la “catastrofe” dai miei amici palestinesi. Da allora la nostra festa la vivo con una venatura di tristezza. Mi voglio impegnare per una nuova data, quella che sarà festa per noi israeliani e per i palestinesi. Quella sarà una festa di gioia piena». Dentro questa frase c’è un mondo intero: l’etica, la politica, la concretezza delle relazioni che distruggono i muri e scelgono di stare sulle soglie che non tradiscono le memorie, ma aprono al futuro. Non esiste una verità condivisa. Ma esiste un’urgenza: vedersi, ascoltarsi, riconoscersi – anche attraverso il dolore. Perché se ancora oggi l’una parte considera la memoria dell’altra come una menzogna o una minaccia, non ci sarà pace. Solo la ripetizione infinita delle stesse date, in forme sempre più tragiche.
Due anni dopo il 7 ottobre, le parole si sono moltiplicate, ma il buio è rimasto e ogni parte continua a contare solo i propri morti, a urlare la propria verità, a ignorare l’umanità dell’altro.E così le date si accumulano: Nakbà, Intifada, pogrom, stragi, esodi, assedi. Ognuna chiama vendetta, nessuna chiama giustizia.
Finché la memoria sarà solo un’arma e non una ferita di cui prendersi cura, nessun futuro sarà possibile.
E se si sceglie la forza invece della parola, la paura invece della dignità, allora il prossimo 7 ottobre è già scritto. Solo non sappiamo ancora dove – né per chi.